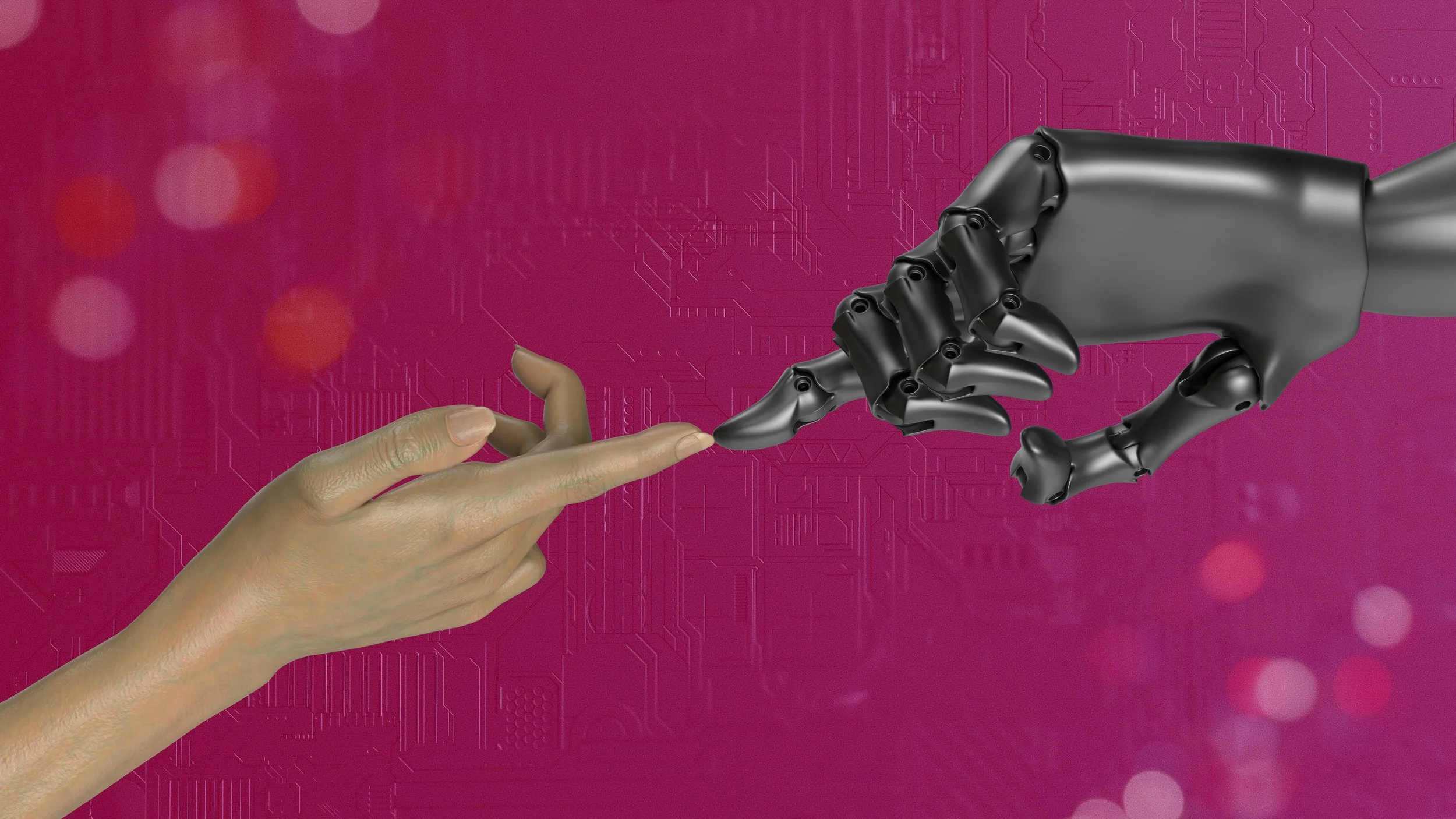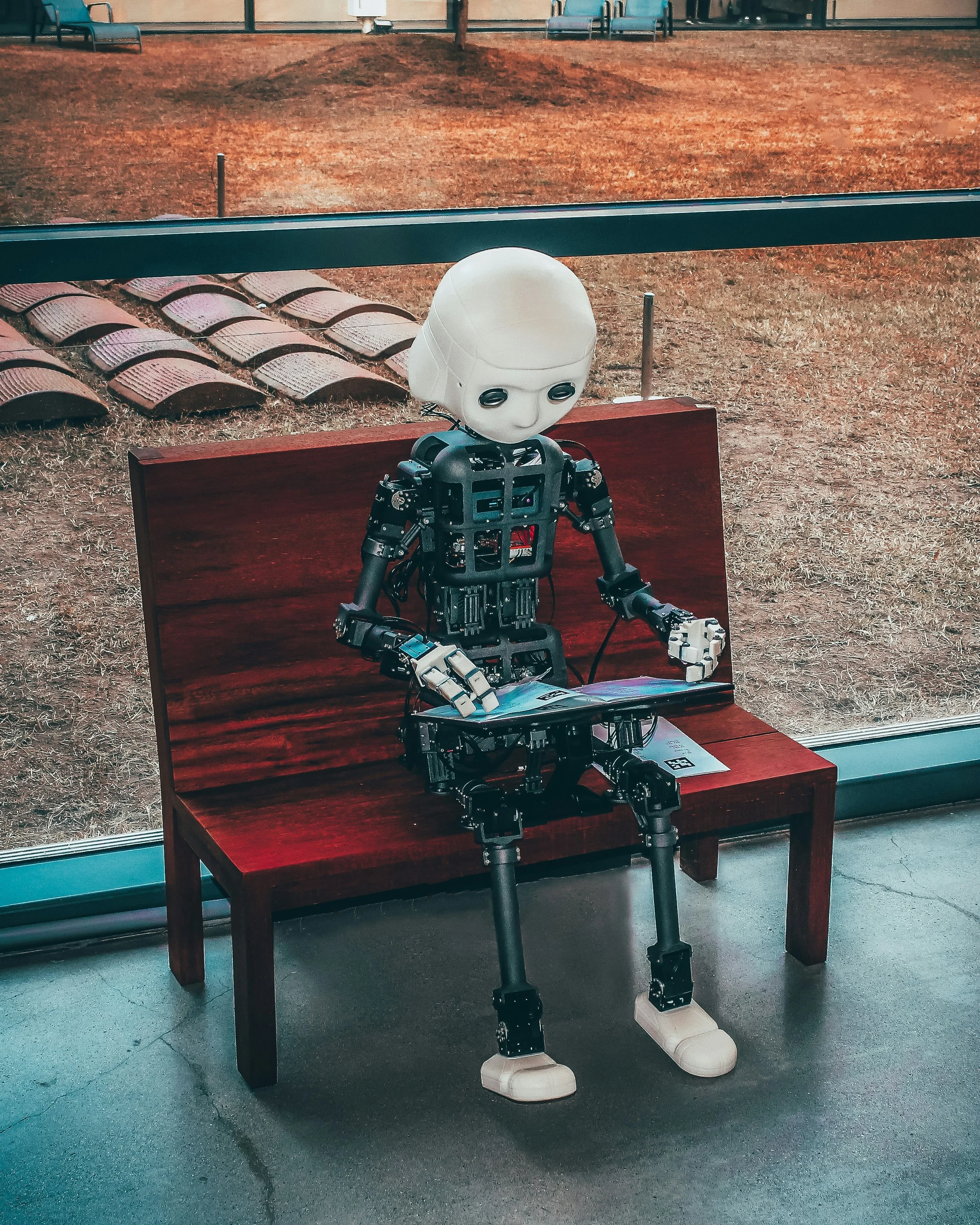Intelligenza artificiale a scuola: educare alla consapevolezza digitale
Di intelligenza artificiale si parla da decenni. Ma non è sempre stata quella cosa che oggi associamo a ChatGPT, immagini generate in pochi secondi e compiti scolastici fatti (forse) troppo bene. L’IA è nata nei laboratori degli anni ’50, tra formule, modelli matematici e sogni di replicare il pensiero umano. Il termine intelligenza artificiale è stato coniato nel 1956 durante la conferenza di Dartmouth, organizzata da John McCarthy, considerato il vero padre dell'AI. Insieme a lui c'erano anche Marvin Minsky, Claude Shannon e Allen Newell, tutti pionieri in campi collegati. Negli anni ’60, McCarthy immaginò un futuro in cui le persone avrebbero potuto accedere a programmi e potenza di calcolo “on demand” tramite la rete, anticipando di fatto il concetto di cloud computing. In un’epoca in cui i computer riempivano intere stanze e internet non esisteva, lui parlava già di una “utility computing” simile alla corrente elettrica: accendi l’interruttore e usi l’intelligenza come un servizio
“l’unico modo per essere sicuri che i computer non prendano il controllo è non dare loro quel potere”
Nel corso dei decenni, l’idea si è evoluta. Dall’intelligenza simbolica, fatta di regole logiche e strutture rigide, siamo passati a modelli più flessibili e adattivi, capaci di apprendere dai dati e migliorarsi nel tempo. È così che è nato il machine learning. Ed è così che, piano piano, l’AI è uscita dai laboratori e ha cominciato a insinuarsi nella quotidianità: nei motori di ricerca, nei suggerimenti musicali, nei filtri antispam, nei percorsi che ci propone il navigatore. Senza troppo clamore, ha iniziato a decidere al posto nostro. Che poi tutti spaventati dall’intelligenza artificiali e dal fatto che “sia difficile da usare” ma la realtà è che abbiamo sempre avuto i modelli predittivi a nostra disposizione. Il T9 dei telefoni, faceva previsioni in base al nostro modo di scrivere, anticipava le parole, ci suggeriva cosa volevamo dire ancor prima di pensarci bene. Non lo chiamavamo “intelligenza artificiale”, ma lo era. Era un algoritmo semplice, ma capace di apprendere dai nostri errori, di adattarsi al nostro lessico, alle nostre abbreviazioni. E più lo usavamo, più diventava efficace.
È questo il paradosso: l’AI fa paura quando la vediamo come un’entità misteriosa e distante, ma è sempre stata lì, silenziosa, ad aiutarci a scegliere un film, correggere un messaggio, trovare il percorso più veloce per tornare a casa. La differenza oggi è che ha assunto forme più complesse, più autonome, e soprattutto più visibili. Ma il principio è lo stesso: imparare da noi, con noi, per semplificarci la vita. Sta a noi capire come guidarla, piuttosto che lasciarci guidare senza accorgercene. E con questa nuova capacità, l’AI non si è solo avvicinata alla creatività umana: ha cominciato a metterne in discussione i confini. Cosa significa davvero “creare”, oggi? È ancora frutto di intuizione e fatica, oppure basta saper descrivere bene cosa si vuole vedere, sentire, leggere? Di chi è un’idea generata da una macchina? Di chi scrive il prompt? Di chi ha costruito il modello?
E poi: possiamo ancora distinguere ciò che è reale da ciò che è solo verosimile? Video che sembrano veri, voci che sembrano autentiche, volti che non appartengono a nessuno e che, allo stesso tempo, somigliano a tutti. Il confine si fa sottile. E non sempre siamo pronti ad accorgercene.
È nata l’intelligenza artificiale generativa.
L’intelligenza artificiale generativa è già nelle scuole italiane. Dalla scrittura dei testi alle immagini, fino ai compiti svolti con ChatGPT o strumenti simili: l’AI sta cambiando il modo in cui studenti e docenti vivono l’educazione. Ma siamo pronti a gestirla in modo consapevole? Quella che oggi troviamo nei software che scrivono testi su richiesta, nei programmi che creano illustrazioni in pochi secondi, nei video realistici che mescolano verità e finzione. E qui il discorso si complica. Perché non siamo più davanti a uno strumento che semplicemente supporta: siamo di fronte a un sistema che, in alcuni casi, può sostituirsi. E lo fa in modo sorprendentemente fluido, spesso indistinguibile da una produzione umana. Ecco perché oggi tutti ne parlano. Perché l’intelligenza artificiale non è più un tema per addetti ai lavori. È diventata questione culturale, sociale, educativa. È entrata nelle scuole. Non nei programmi, non nei piani ministeriali — almeno non ancora in modo organico — ma nelle abitudini degli studenti. Nelle loro ricerche, nei testi che consegnano, nei video che guardano. È presente anche quando non la nominiamo. E spesso la usano prima di averne compreso davvero il funzionamento, le implicazioni, i rischi.
Che ruolo può avere la scuola in tutto questo? Come possiamo trasformare l’IA da scorciatoia per finire i compiti a opportunità per allenare pensiero critico, etica, creatività
La sfida non è tecnologica ma educativa perché se è vero che non possiamo impedire l’uso dell’intelligenza artificiale, possiamo però insegnare a farne un uso consapevole. A distinguere tra chiedere e capire, tra ottenere una risposta e imparare a farsi domande. E forse, in tutto questo, la scuola ha un’occasione unica: quella di tornare a essere uno spazio in cui si coltiva l’intelligenza: quella umana e quella lenta. Quella che si sporca le mani, che sbaglia, che cambia idea. Ma che, proprio per questo, non può essere replicata da nessun algoritmo.
Negli ultimi anni, la presenza dell’intelligenza artificiale nelle scuole italiane ha registrato una crescita significativa. Oggi il 78 % degli studenti utilizza regolarmente strumenti basati sull’IA per lo studio e circa 1 alunno su 4 li impiega ogni giorno. Un dato che, da solo, racconta più di tante parole. Questo uso diffuso, spesso informale, pone una domanda ineludibile: come possiamo trasformare questa tendenza in una leva pedagogica reale?
Il PNRR (piano per la resilienza nazionale) che ha investito miliardi in tanti settori, tra cui anche la scuola – ha messo in campo risorse importanti, ad esempio con il piano Scuola 4.0, sono stati stanziati 2,1 miliardi di euro per modernizzare 100k classi e creare laboratori digitali. Parallelamente, i decreti ministeriali 65 e 66 hanno previsto investimenti su formazione docenti in competenze digitali, coding, intelligenza artificiale e cybersecurity. Il risultato? Una rete di scuole più attrezzate, non solo di tecnologie, ma anche di spazi e competenze per integrare la tecnologia in modo consapevole nei percorsi didattici.
Eppure, viene da chiedersi: è davvero così? Perché, al di là dei bandi, dei fondi e delle conferenze stampa, troppe volte la scuola italiana sembra rincorrere l’innovazione più per dovere che per visione. Più per stare al passo con il mercato che per offrire alle nuove generazioni strumenti per pensare, dubitare, creare. L’intelligenza artificiale, usata dagli studenti come scorciatoia per finire i compiti o come stampella per colmare le proprie insicurezze, rischia di diventare l’ennesimo strumento sterile, se non impariamo a raccontarla, decostruirla, contestualizzarla. Ho avuto la fortuna di formare studenti e docenti grazie a questi progetti. E vedere come alcune scuole stanno evolvendo – rispetto a quando le frequentavo io – mi riempie di gioia e speranza. Speranza per le nuove generazioni, che forse potranno davvero sostituire la lavagna col gesso con esperienze immersive, dialoghi aperti col resto del mondo, scambi di idee e prospettive. Che poi, a ben vedere, è anche per questo che internet era nato: per connettere, non per automatizzare.
Ma la trasformazione tecnologica ha senso solo se accompagnata da una trasformazione culturale. La scuola del futuro non ha solo più tecnologia: ha più consapevolezza.
Se vuoi portare percorsi formativi sull’intelligenza artificiale nella tua scuola o nel tuo ente, contattaci. È tempo di un'educazione digitale umana e sostenibile.